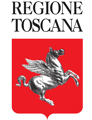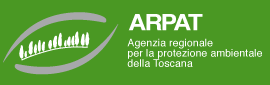Contaminazione da PFAS in Toscana
Le attività di ARPAT
Cosa sono i PFAS
Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una vasta classe di composti chimici di sintesi caratterizzati da una catena di atomi di carbonio completamente (perfluoro) o parzialmente (polifluoro) fluorurata e da un gruppo funzionale polare.
Il numero di PFAS conosciuti varia a seconda dell’organizzazione che ha eseguito la stima e si passa dai 4.700 recensiti da OCSE nel 2021 agli oltre 14.000 valutati da EPA.
La particolare struttura molecolare conferisce ai PFAS una eccezionale stabilità chimica, elevata resistenza al calore e proprietà tecnologiche uniche e modulabili.
Per queste caratteristiche, i PFAS sono stati utilizzati sin dagli anni '50 in numerose applicazioni industriali, che spaziano dalla galvanica al settore cartario e tessile, nonché in prodotti di uso comune come rivestimenti antiaderenti, tessuti impermeabili, schiume antincendio, cosmetici, pesticidi, e imballaggi alimentari.
Tuttavia, le stesse peculiarità alla base del loro successo merceologico rendono i PFAS estremamente persistenti nell'ambiente. Per questo motivo sono noti come "sostanze chimiche eterne" (Forever Chemicals), poiché non si degradano facilmente con processi naturali come l'idrolisi, la fotolisi o la degradazione microbica.
A livello ambientale, i PFAS sono ubiquitari in tutti i comparti, a partire da quello idrico; tendono ad accumularsi nel suolo e nei sedimenti e alcuni di essi danno luogo a fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione, termine con cui si intende la crescente concentrazione di una sostanza nei tessuti di organismi a livelli trofici più elevati in una catena o rete alimentare.
La loro presenza è stata rilevata anche in aree remote del pianeta, evidenziando l’elevata persistenza e mobilità ambientale di queste sostanze.
I composti tradizionalmente più studiati e rilevati nell’ambiente sono l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), entrambi classificati come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT).
Il quadro normativo europeo sui PFAS
Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha adottato importanti misure per ridurre l'esposizione ai PFAS e limitarne l'uso:
- D.Lgs. 18/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 2020/2184: fissa limiti per la somma di 20 PFAS nelle acque destinate al consumo umano (0,10 µg/L) e un limite più generale per il totale PFAS (0,50 µg/L), da recepire negli Stati membri entro gennaio 2026.
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH”: PFOS, PFOA, PFNA e altre sostanze correlate sono state progressivamente incluse tra le sostanze soggette a restrizione o autorizzazione. Nel 2023, cinque Stati membri (Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Norvegia) hanno proposto una restrizione globale su oltre 10.000 PFAS, attualmente in valutazione presso l'ECHA.
- Nuovo Regolamento sugli imballaggi (UE 2025/40): prevede il divieto di PFAS negli imballaggi alimentari a partire dal 2026.
- D.Lgs 172/2015 di recepimento della Direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE: introducono gli standard di qualità ambientale (SQA-MA e SQA-CMA) per il PFOS nelle acque superficiali, recepiti in Italia con il D.Lgs. 172/2015. Ulteriori soglie sono previste per altri cinque composti perfluoroalchilici.
- Decreto MATTM 6 luglio 2016 di recepimento Direttiva 2014/80/UE: fissa valori soglia per cinque PFAS nelle acque sotterranee.
I soggetti deputati all’applicazione della normativa sopracitata sono numerosi tra cui Aziende Sanitarie ed ARPAT. Per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano, la competenza per il loro controllo è posta in capo alle Aziende sanitarie locali; ad ARPAT, invece, spetta, tra l’altro, il controllo delle acque superficiali prima che queste siano rese potabili dal gestore del servizio idrico e prima dell’immissione nella rete acquedottistica.
Le attività di ARPAT
In Toscana, ARPAT ha avviato il monitoraggio dei PFAS nel 2016, dotandosi di strumentazioni ad altissima tecnologia per l'analisi di queste sostanze in concentrazioni molto basse. L'Agenzia ha sviluppato e ottimizzato metodiche di cromatografia liquida abbinata a spettrometria di massa ad alta risoluzione (LC-HRMS), raggiungendo i bassissimi limiti di rilevazione richiesti dalla normativa di settore.
Dal 2017 ARPAT esegue le analisi delle sei sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), previste dall’attuale normativa ambientale di settore, nell’ambito del programma di monitoraggio sui corpi idrici della Toscana (fiumi, laghi e acque sotterranee e di transizione). Si segnala che il solo PFOS, ricercato anche nel biota, è l’unica sostanza perfluoroalchilica attualmente prevista per la classificazione dello stato chimico delle acque fluviali e di transizione, ai sensi del D.Lgs 172/2006.
I dati del monitoraggio sono pubblicati regolarmente sul sito Web di ARPAT tramite le specifiche banche dati, suddivise tra le matrici di
- acque sotterranee (MAT),
- acque superficiali - fiumi e laghi (MAS),
- acque superficiali, transizione e marine costiere (MAR).
I dati possono essere agevolmente filtrati e scaricati e sono corredati di tutte le informazioni relative alla stazione di prelievo e metodica analitica.
Le attività di monitoraggio ambientale di ARPAT in materia di PFAS possono essere riscontrabili anche nelle pubblicazioni dell’Agenzia reperibili sul sito Web, in particolare
- Monitoraggio ambientale dei corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione)
- Annuario dei dati ambientali.
In aggiunta al monitoraggio sui corpi idrici della Toscana, con la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 555 del 2024, è stata avviata un’attività di supporto tecnico alla Regione Toscana, da svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari, che prevede la verifica della presenza dei PFAS nei cicli produttivi e le possibili soluzioni per mitigare le problematiche connesse col loro utilizzo.
Sebbene in Toscana non risultino produttori diretti di PFAS (come invece accade o accadeva in Veneto o Piemonte), nell’ottica di anticipare un quadro normativo in evoluzione (che ad oggi non prevede limiti specifici per le acque di scarico), ARPAT sta valutando la possibilità di inserire nel proprio catalogo delle prestazioni anche l’analisi dei PFAS negli scarichi di impianti industriali.