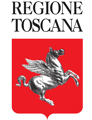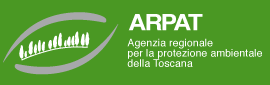La gestione sostenibile della costa, dalle criticità alle strategie di soluzione
I territori costieri affrontano sfide complesse che richiedono un approccio integrato e condiviso e rendono necessario il confronto e la messa in rete di competenze e conoscenze, per poter generare soluzioni comuni e strategie efficaci
Nell’ambito della Biennale del mare, il convegno sulla Gestione sostenibile della costa: dalle criticità alle strategie di soluzione, tenutosi il pomeriggio del 14 maggio, ha visto riunirsi istituzioni locali, autorità ambientali, esperti e rappresentanti europei per esaminare i principali strumenti normativi e le buone pratiche messe in campo a livello regionale e locale, anche con l’obiettivo di far emergere istanze locali da portare all’attenzione delle istituzioni europee.
L’Assessora alla rigenerazione urbana del Comune Livorno Silvia Viviani, aprendo i lavori del convegno, ha richiamato il tema della conoscenza da cui è necessario partire per parlare di gestione delle coste e in generale delle acque, conoscenza che però va anche condivisa e l’occasione del convegno vuole essere proprio un momento di condivisione in cui i diversi soggetti coinvolti possono aiutare a comporre il quadro conoscitivo.
Nei saluti introduttivi, l’Assessora regionale all’Ambiente Monia Monni ha affermato che l'approccio "One Health", in un tempo caratterizzato dagli effetti dei cambiamenti climatici, è fondamentale per sviluppare politiche integrate per la conversione ecologica, a partire dalla consapevolezza che la salute stessa dei nostri mari, la tutela dell'ambiente e della biodiversità marina sono fortemente interconnessi con la salute umana. Il mare rappresenta quindi una fondamentale risorsa ambientale e socioeconomica ed è per questo che la Regione ha confermato il proprio impegno anche sul tema dell'erosione costiera, un fenomeno che ha deciso di affrontare scegliendo un modello di governance partecipativo, con il coinvolgimento di Comuni e portatori di interesse, e orientato alla resilienza e alla sostenibilità.
Lorenzo Mannelli, Direttore generale della DG Tecnologie dell'informazione e sicurezza informatica del Parlamento europeo, ha richiamato il valore del mare, che ha un ruolo strategico e cruciale nella transizione ecologica prospettata dal quadro normativo europeo, essendo regolatore climatico, serbatoio di biodiversità e fonte di innovazione sostenibile. Nel contesto della sostenibilità marittima, la digitalizzazione è utile per armonizzare e mettere in rete i diversi sistemi e per raggiungere in primis una maggiore efficienza. L’Unione europea parla infatti di “ambiente unico marittimo europeo”, un sistema di interfaccia interoperabile istituito per migliorare la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo, attraverso lo scambio di dati tra diversi soggetti pubblici e privati (armatori, autorità portuali, dogane, autorità sanitarie, ambientali etc.).
Ha quindi citato tre progetti finanziati con il programma Horizon:
- Digital Twin of the Ocean, una replica digitale dell’oceano, utile per testare scenari ipotetici e simulare eventi che riguardano il mare, tra cui gli impatti ambientali, prima che questi siano verificati ex post;
- Blue-Cloud 2026, una piattaforma per la raccolta dati degli oceani e delle acque che garantisce accesso semplificato a set di dati multidisciplinari;
- VesselAI, basato sull'intelligenza artificiale, che simula e previene il comportamento e le manovre delle navi. Tutti questi strumenti sono in grado di trasformare i porti in sistemi intelligenti capaci di affrontare le sfide ambientali e logistiche del futuro.

Pietro Rubellini, Direttore generale di ARPAT, è intervenuto parlando di gestione sostenibile delle acque alla luce delle sfide poste dal cambiamento climatico, i cui effetti si stanno iniziando ad osservare anche dai dati che l’Agenzia quotidianamente raccoglie.
A livello locale gli impatti del cambiamento climatico si possono infatti osservare anche sulla qualità ecosistemica dei comparti ambientali, a partire dalle acque. I regimi di ricarica delle falde sotterranee ricevono meno acqua perché la maggior parte delle piogge se ne va per ruscellamento superficiale che porta anche ad un "effetto pistone" sui corsi d'acqua superficiali dove si concentrano nella stagione di secca gli inquinanti, che, alla prima pioggia intensa, finiscono in mare, impattando sulla qualità delle acque di balneazione. Il depauperamento delle falde sta inoltre
agevolando una risalita nell'entroterra del cuneo salino, cioè l'acqua salmastra dal mare, con un peggioramento qualitativo della risorsa idrica e fenomeni di salinizzazione dei suoli.
 Il mare è anche terreno comune di cooperazione transfrontaliera e ne ha portato testimonianza Filippo Giabbani, dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Marittimo-IT FR-Maritime, programma che opera in un’area estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici ed esposta ai rischi naturali. I progetti finanziati dall’Interreg si occupano quindi anche di mitigazione, adattamento e risposta alle emergenze climatiche. È importante sottolineare come il 30% delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea è dedicato al cambiamento climatico e alla messa in opera di progetti a cui viene chiesto il raggiungimento della neutralità climatica. Ha quindi rivolto un appello, in prima battuta ai decisori politici, affinché non venga disperso il patrimonio di conoscenze e soluzioni frutto dei progetti, che dovrebbero entrare a regime nelle politiche e nei finanziamenti regionali e locali.
Il mare è anche terreno comune di cooperazione transfrontaliera e ne ha portato testimonianza Filippo Giabbani, dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Marittimo-IT FR-Maritime, programma che opera in un’area estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici ed esposta ai rischi naturali. I progetti finanziati dall’Interreg si occupano quindi anche di mitigazione, adattamento e risposta alle emergenze climatiche. È importante sottolineare come il 30% delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea è dedicato al cambiamento climatico e alla messa in opera di progetti a cui viene chiesto il raggiungimento della neutralità climatica. Ha quindi rivolto un appello, in prima battuta ai decisori politici, affinché non venga disperso il patrimonio di conoscenze e soluzioni frutto dei progetti, che dovrebbero entrare a regime nelle politiche e nei finanziamenti regionali e locali.
 Ada Polizzi, del settore Acqua di Utilitalia, ha introdotto gli aspetti salienti della nuova Direttiva acque reflue (2024/3019) che abroga e sostituisce la precedente 91/271 e che pone nuove sfide al settore della risorsa idrica e quindi anche del mare. Tra le novità introdotte vi è l’obbligo di reti fognarie anche per i piccoli agglomerati con 1000-2000 abitanti equivalenti, precedentemente esclusi, l’introduzione dei Piani integrati gestione acque reflue, l’obbligo di trattamenti terziari per i nutrienti e trattamenti quaternari per i microinquinanti, l’introduzione del principio “chi inquina paga” per i produttori chimico-farmaceutici, la neutralità energetica per impianti e reti, il riutilizzo di acque reflue trattate soprattutto in campo agricolo, la richiesta della sorveglianza sanitaria delle acque reflue, il recupero di risorse da fanghi di depurazione, il monitoraggio di scarichi, fanghi, emissioni, inquinanti da parte degli impianti e la trasparenza dei relativi dati per consentire la partecipazione attiva della popolazione.
Ada Polizzi, del settore Acqua di Utilitalia, ha introdotto gli aspetti salienti della nuova Direttiva acque reflue (2024/3019) che abroga e sostituisce la precedente 91/271 e che pone nuove sfide al settore della risorsa idrica e quindi anche del mare. Tra le novità introdotte vi è l’obbligo di reti fognarie anche per i piccoli agglomerati con 1000-2000 abitanti equivalenti, precedentemente esclusi, l’introduzione dei Piani integrati gestione acque reflue, l’obbligo di trattamenti terziari per i nutrienti e trattamenti quaternari per i microinquinanti, l’introduzione del principio “chi inquina paga” per i produttori chimico-farmaceutici, la neutralità energetica per impianti e reti, il riutilizzo di acque reflue trattate soprattutto in campo agricolo, la richiesta della sorveglianza sanitaria delle acque reflue, il recupero di risorse da fanghi di depurazione, il monitoraggio di scarichi, fanghi, emissioni, inquinanti da parte degli impianti e la trasparenza dei relativi dati per consentire la partecipazione attiva della popolazione.
Gli adempimenti richiesti agli stati membri necessitano di un’importante innovazione tecnologica e, di conseguenza, di un notevole investimento economico. Le scadenze previste per gli adempimenti sono sicuramente ambiziose, ma il raggiungimento degli obiettivi finali procede per tappe intermedie che si sviluppano nell’arco dei prossimi 20 anni.
Elena Bartoli dell’Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha ricordato che l’Autorità di distretto si occupa, in primo luogo, di pianificazione di bacino: elabora e approva il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui in particolare il Piano di gestione del rischio di alluvioni e il Piano di gestione delle acque, due importanti piani in materia di alluvioni e di acque, redatti ai sensi delle direttive europee 2000/60/CE e 2007/60/CE. Il Piano di gestione delle acque è un Masterplan per tutto quello che concerne la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee con la finalità di raggiungere il buono stato ambientale dei corpi idrici e garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche. L’Autorità è in grado di fornire in continuo una fotografia aggiornata dello stato di salute dei fiumi e degli obiettivi fissati per ciascuno di essi, definendo tempistiche e misure per il raggiungimento del buono stato di qualità delle acque. Dal punto di vista infrastrutturale negli ultimi anni è emersa l'esigenza di inserire i vari interventi in contenitori unici, come avvenuto per l'impianto del Rivellino (depuratore di Livorno) che è stato inserito nel Piano di gestione delle acque, questo perché è sempre più necessario andare avanti in maniera unita.
L'erosione costiera è stato il tema al centro dell’intervento di Marco Masi, dirigente del Settore Tutela Acqua e Costa della Regione Toscana; infatti, essa rappresenta una delle criticità ambientali con oltre 250 km di costa bassa, particolarmente esposta ai cambiamenti climatici, al moto ondoso e alla pressione antropica.
Le trasformazioni naturali e artificiali hanno alterato nel tempo l'equilibrio dinamico tra spiaggia, dune e corsi d'acqua, rendendo necessaria un'azione sistemica e strutturata. Per questi motivi, la Regione ha elaborato il Masterplan per la tutela della costa, uno strumento tecnico e programmatico che si basa su un approccio sistemico, che potrà guidare le azioni regionali nel medio-lungo periodo (15-20 anni), con l'obiettivo di aumentare la resilienza del territorio e ridurre la vulnerabilità degli ecosistemi e degli insediamenti umani. Nel quadro delle strategie per la mitigazione dell’erosione costiera (quando si agisce sulle cause) e adattamento a tale fenomeno (quando si agisce per contenere gli effetti), le opere di difesa possono essere inserite nelle azioni tese alla riduzione delle perdite di sedimenti e, indirettamente, in quelle che sono le azioni di alimentazione artificiale delle spiagge.
L'obiettivo è quello di realizzare interventi di gestione del demanio marittimo che consentano di incrementare la resilienza del sistema costiera per proteggere e promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone costiere, favorendo al contempo una sinergia, un livello di governance fra l’azione regionale e le competenze delle amministrazioni comunali.
Per favorire questo approccio e confrontarsi con altre realtà nazionali ed europee, la Regione Toscana è partner di alcuni progetti europei ed è impegnata attualmente nella redazione di linee guida tecniche condivise, fondamentali per semplificare le autorizzazioni e migliorare la qualità progettuale e la gestione dei sedimenti. In merito a quest’ultimo punto è stato sottoscritto l’Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, ISPRA, ARPAT e LaMMA, con l'obiettivo di valorizzare la risorsa sedimento presente lungo il litorale toscano, ai fini della tutela della costa e del superamento delle criticità esistenti, con particolare riferimento alle problematiche dovute alle caratteristiche geochimiche, in un’ottica di economia circolare, anche attraverso le attività di movimentazione finalizzate alla difesa e al rimodellamento dei litorali delle differenti aree costiere.
L'erosione costiera è infatti un fenomeno dinamico, aggravato dal cambiamento climatico e dalla riduzione dell'apporto naturale di sedimenti e per questo motivo la Regione Toscana ha scelto un modello di governance partecipativo, orientato alla resilienza e alla sostenibilità.
I principali elementi di innovazione includono:
- l'uso integrato di sedimenti da cava, dragaggi e materiali riutilizzati, valorizzando anche quelli classificati come sottoprodotti;
- il rafforzamento del monitoraggio costiero e della conoscenza tecnico-scientifica;
- la collaborazione stabile con le università toscane e le agenzie ambientali, con la promozione e sostegno a progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
L'obiettivo è mantenere un approccio adattivo, integrato e basato sull'evidenza scientifica, che consenta di rispondere in modo efficace alle sfide future.
Alessandro Mazzei, direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana, ha illustrato il ruolo strategico dell’Autorità Idrica Toscana che nelle sue attività ha dato priorità a quattro aspetti fondamentali:
- realizzazione investimenti
- qualità del servizio
- monitoraggio e controllo dei gestori
- pianificazione per la resilienza ai cambiamenti climatici
Nei primi mesi del 2024 sono state risolte strutturalmente le ultime criticità legate agli agglomerati in infrazioni europee. AIT si è dotata di una dashboard che permette di confrontare le prestazioni dei gestori e analizzare nei singoli territori comunali le migliori prestazioni e le principali criticità anche al fine di essere più efficaci nel programmare gli investimenti. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, gli obiettivi di AIT sono: ridurre le perdite idriche, completare le «autostrade dell’acqua», garantire l’autonomia idrica delle isole e della costa, attraverso ad esempio l’uso di dissalatori.
Simone Gheri, Direttore ANCI Toscana, ha sottolineato come l’iniziativa sia utile per scambiarsi opinioni e fare il punto insieme; è importante e fondamentale il coinvolgimento degli enti locali dove si decidono le norme ed i regolamenti, a partire dall'Europa fino alla Regione. Questo coinvolgimento si rende necessario perché sono poi i Comuni che devono mettere a terra i progetti e per questo è fondamentale la formazione per coloro che lavorano nelle amministrazioni comunali ed altresì la collaborazione fra enti, senza dimenticare gli investimenti, che servono ad attirare le migliori energie, in termini di risorse umane.
Ha concluso il pomeriggio di lavori Giuseppe Sciacca, della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa, che ha indicato impegno affinché attraverso la manifestazione le pratiche dei territori, le proposte e le criticità arrivino alla comunità europea in modo da garantire la vicinanza delle politiche europee alle aree del Mediterraneo. Ha illustrato il sistema promosso dalla Direttiva Marine Strategy rilevando le criticità nel trasformarne i contenuti in politiche efficaci su cui ha chiesto a tutti collaborazione.