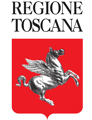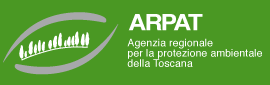Letture verdi: a colloquio con Antonello Pasini
Per la rubrica Dialoghi con l'autore e l'autrice, abbiamo rivolto alcune domande a Antonello Pasini, attivo nella divulgazione scientifica e non solo e autore di molti libri sul clima e cambiamento climatico, tra cui "La sfida climatica"
Finalmente uno scienziato che, con coraggio, scrive che non basta enumerare dati e teorie scientifiche per convincere i politici a prendere decisioni tese a contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Nel libro “La sfida climatica. Dalla scienza alla politica: ragioni del cambiamento”, Antonello Pasini, fisico, climatologo e ricercatore presso il CNR, affronta in modo pragmatico anche il rapporto tra scienza, mondo dell’informazione e politica.
Professore, la prima parte del libro spiega, in termini scientifici, perché possiamo ormai affermare che il cambiamento climatico – i cui effetti primari includono l’aumento delle temperature – è attribuibile all’azione umana: combustioni fossili, deforestazione, agricoltura non sostenibile sono i principali ambiti su cui intervenire per contrastare gli effetti del clima che cambia. Può sintetizzare ai nostri lettori e alle nostre lettrici le prove più solide di questa attribuzione?
Il clima è un sistema complesso e va studiato con i metodi della scienza della complessità, in particolare con i modelli che ricostruiscono questa complessità nel “laboratorio virtuale” dei supercomputer. Qui, una volta elaborati modelli validi, possiamo anche fare “esperimenti” che non potremmo eseguire nella realtà. Per esempio, possiamo capire cosa sarebbe accaduto se gli influssi umani (soprattutto le emissioni di CO2) fossero rimasti fermi al valore di metà ‘800: si vede chiaramente che in questo caso il riscaldamento globale recente (quello degli ultimi 60 anni) non ci sarebbe stato. Anche altri modelli, molto diversi e completamente indipendenti, come i modelli di intelligenza artificiale a rete neurale sviluppati e applicati a questo problema da me e dai miei collaboratori, hanno mostrato gli stessi risultati. Inoltre, l’anidride carbonica in surplus in atmosfera ha una chiara firma umana: non si tratta del risultato di emissioni naturali ma antropiche, come ci mostrano le analisi degli isotopi del carbonio delle molecole di CO2.
Gli scienziati hanno anche cominciato a studiare, attraverso i modelli climatici, il legame tra eventi estremi (come ad esempio alluvioni, siccità) e cambiamento climatico di origine antropica. Quali evidenze ci sono oggi?
Fino a pochi anni fa, quando si chiedeva a un climatologo se un determinato evento estremo fosse attribuibile al cambiamento climatico di origine antropica, egli diceva che non lo si poteva sapere ma occorreva guardare la tendenza degli eventi sul lungo periodo. Oggi, invece, tramite modelli meteo-climatici, possiamo far correre il modello ricostruendo il fenomeno nella situazione reale e poi farlo girare in condizioni preriscaldamento globale, andando a vedere se l’intensità o la frequenza di questo fenomeno sarebbe stata diversa. Studi di questo genere hanno mostrato per esempio che, nel 2024, in 26 di 29 eventi estremi studiati c’è stato un chiaro influsso del cambiamento climatico di origine antropica sull’intensificazione o maggior frequenza di questi eventi.
Venendo al Mediterraneo, e in particolare all’Italia: qui le temperature stanno aumentando più che in altre parti del mondo. Nel suo ultimo libro, “La sfida climatica”, lei afferma che siamo in una sorta di punching ball climatica, “a un pugno da sud corrisponde una reazione da nord”. Ci spiega meglio quest’immagine?
Mentre nei decenni scorsi eravamo abituati a una circolazione prevalente da ovest a est e a influssi atlantici come nel caso dell’anticiclone delle Azzorre che dominava le nostre estati, adesso la circolazione si mette un po’ più frequentemente lungo la direttrice sud-nord, con afflussi di anticicloni africani, e non solo in estate. Di fatto, il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale e tropicale. Così arrivano anticicloni africani che portano gran caldo e siccità; ma il problema vero è che, quando si ritirano verso sud o si spostano a est, dopo aver riscaldato aria, suoli e soprattutto i mari circostanti l’Italia, lasciano la porta aperta all’arrivo di correnti più fredde dai quadranti settentrionali, che creano un contrasto termico molto forte e producono precipitazioni violente. In sostanza, siamo colpiti da un pugno da sud, con gli anticicloni africani, ma subito dopo – come con il palloncino del punching ball che torna indietro – veniamo investiti da una reazione da nord. Il clima del Mediterraneo si è estremizzato.
Un capitolo importante riguarda le azioni per ridurre le emissioni di gas serra. A suo avviso stiamo andando nella giusta direzione o bisogna accelerare?
La produzione di energia da fonti rinnovabili sta aumentando dovunque nel mondo, ma non nella misura necessaria per evitare di superare la soglia dei 2 °C di temperatura media globale rispetto all’epoca preindustriale. Occorre sicuramente mettere più impegno in queste azioni, anche se interessi dell’industria fossile e una certa reviviscenza di sovranismi e di posizioni negazioniste, non favoriscono certo questo percorso. In questa situazione, l’impegno personale e di gruppo può fare la differenza, anche in termini di spinta dal basso verso la politica.
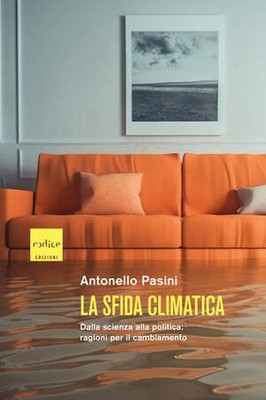 Un altro tema centrale è quello dei ghiacciai, che stanno arretrando rapidamente in diverse parti del mondo. Perché è così importante monitorarli e preoccuparsi di ciò che sta accadendo?
Un altro tema centrale è quello dei ghiacciai, che stanno arretrando rapidamente in diverse parti del mondo. Perché è così importante monitorarli e preoccuparsi di ciò che sta accadendo?
La situazione dei ghiacciai è molto critica. Da un lato, i ghiacciai mostrano un’inerzia pericolosa: essi stanno ancora rispondendo lentamente al riscaldamento degli ultimi decenni e non sono in equilibrio con la temperatura attuale; così, se anche la temperatura non aumentasse più, continuerebbero a fondersi ancora per decenni nel futuro. D’altro lato, più studiamo la dinamica dei ghiacci e più vediamo che essi non rispondono solo gradualmente, ma anche con eventi bruschi. In Antartide, in particolare, alcuni ghiacciai sono a rischio collasso. Se questo accadesse, il mare si potrebbe innalzare repentinamente di circa 60 cm, facendo rivedere al rialzo tutte le stime precedenti.
Dal suo ultimo libro, "La sfida climatica", emerge la profonda consapevolezza che la conoscenza scientifica da sola non basta: serve anche il forte impegno della comunicazione e della politica. In che modo è possibile coinvolgere positivamente la “galassia” dell’informazione, in un periodo storico fortemente connotato dalla polarizzazione e dai “bias” conoscitivi ? E, poi, come è possibile instaurare un rapporto costruttivo con il mondo politico?.
È un discorso molto complesso e per una trattazione dettagliata rimando al mio libro, dove dedico due interi capitoli a questi temi. Direi solo che bisogna rompere quelle frontiere invisibili che ci tengono chiusi nelle nostre bolle mediatiche e abituarci a mettere alla prova la nostra visione del mondo con quanto dice la scienza, anziché fare il contrario: spesso, infatti, leggiamo i risultati scientifici con gli “occhiali” della nostra visione del mondo e se questi risultati non ci piacciono, tendiamo a negarne la validità, a oscurarli o addirittura a distorcerli. Tutto ciò accade anche con la politica, con l’aggravante che i politici cercano spesso di risolvere emergenze immediate senza tenere in considerazione che azioni sbagliate possono portare a rendere ancora più grave la crisi climatica di lungo periodo. Nel libro ci sono anche proposte concrete per risolvere queste problematiche.
Concludiamo con una frase presa dal suo ultimo libro: “aver scoperto che la colpa del riscaldamento globale recente è dell’essere umano non è una sciagura, ma una buona notizia”. Se la causa è antropica, significa che possiamo agire collettivamente, meglio se con una “rotta comune” disegnata dalla politica, ma anche singolarmente. Dal suo punto di vista, con quali azioni concrete e quotidiane, ciascuno di noi può contrastare il cambiamento climatico?
Nel momento in cui i grandi della Terra non si mettono d’accordo o lo fanno solo su azioni al ribasso, il contributo di ognuno di noi diventa molto importante. Occorre prendere consapevolezza dei problemi e dunque avere uno stile di vita più sano (la salute del pianeta è anche la nostra salute). Ma questo, ovviamente, non basta: bisogna mettersi in gruppi che agiscano in maniera sostenibile, per esempio sul consumo alimentare, ma anche nella produzione di energia. Oggi si parla molto di comunità energetiche sostenibili ed è importante sapere che tutti possiamo parteciparvi. Infine, è necessario spingere sui politici, affinché mettano la crisi climatica ai primi posti delle loro agende: la spinta dal basso può fare molto.