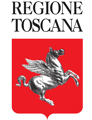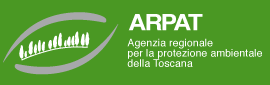Gestione e recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Un passo avanti verso un’edilizia più sostenibile e circolare
Da oltre un anno, è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, che definisce la gestione e il recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, sostituendo il precedente DM 152/2022. Questo nuovo decreto rappresenta un passo avanti verso un’edilizia più sostenibile e circolare.
L’art. 184-ter del Testo Unico Ambientale (decreto legislativo 152/2006) definisce i criteri affinché un rifiuto, dopo essere stato sottoposto ad una operazione di recupero, cessi di essere tale, acquisendo la qualifica di prodotto (il cosiddetto End of Waste).
I criteri prevedono il rispetto delle seguenti condizioni
- utilizzo per scopi specifici: la sostanza/oggetto recuperato deve essere utilizzato per scopi specifici.
- esistenza di un mercato o domanda: deve esistere un mercato o una domanda per la sostanza/oggetto recuperato.
- conformità ai requisiti tecnici e normativi: la sostanza/oggetto recuperato deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare le normative e gli standard applicabili ai prodotti.
- assenza di impatti negativi: l'uso della sostanza/oggetto recuperato non deve comportare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
L’articolo 184-ter prevede che questi criteri possano essere definiti, per specifiche tipologie di rifiuto, con regolamenti; in questa cornice, si inserisce il DM 127/2024 che stabilisce in modo dettagliato i criteri con cui i rifiuti inerti, dopo specifiche operazioni di recupero, cessano di essere classificati come rifiuti per diventare aggregati recuperati utilizzabili in nuove opere come stabilito dallo stesso decreto.
Con questo decreto, si rafforza il percorso verso un uso più efficiente delle risorse nel settore edilizio, riducendo lo smaltimento in discarica e favorendo il recupero di materiali inerti. Una prospettiva che, se applicata correttamente, può contribuire in modo significativo a ridurre l’impatto ambientale dell’edilizia, settore responsabile di una parte rilevante dei rifiuti speciali prodotti nel Paese, e alla diminuzione del consumo di materie prime.
La normativa prevede che il gestore dell’impianto autorizzato alla produzione di aggregato recuperato rilasci, per ciascun lotto prodotto, una dichiarazione di conformità che garantisca che il materiale soddisfi i criteri previsti dal DM. Tale dichiarazione dovrà essere inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.
Inoltre, per dimostrare di aver rispettato i criteri, è previsto che si prelevi un campione da ogni lotto, secondo la UNI 10802, e li conservi presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dall’invio della dichiarazione di conformità. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche, il campionamento avviene in conformità alla norma UNI 932-1.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Sono esentate dall’obbligo di conservare i campioni le imprese registrate EMAS e quelle con certificazione UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato.
Il DM 127/2024 dettaglia i criteri nell’allegato 1
a) Rifiuti ammissibili
Sono rifiuti non pericolosi, suddivisi in due categorie principali:
- rifiuti inerti da costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti): tra cui rientrano materiali come cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, miscele bituminose, terre e rocce da scavo, pietrisco ferroviario e rifiuti misti da cantiere (si veda elenco contenuto nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del DM).
- altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17): che includono scarti di ghiaia, sabbia, argilla, polveri e residui di lavorazione della pietra, scarti ceramici e laterizi, residui di produzione di materiali cementizi, sabbie abrasive di scarto, minerali inerti da trattamento rifiuti, e, fra i rifiuti urbani abbandonati, solo le frazioni inerti da attività edilizie (si veda elenco contenuto nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del DM).
Non sono ammessi i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Si ricorda che è il produttore del rifiuto, destinato ad un impianto per la produzione di aggregato recuperato, è il responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso
il gestore dell’impianto deve adottare una procedura di accettazione che includa:
- controllo della documentazione e ispezione visiva dei rifiuti;
- eventuali controlli supplementari (anche analitici);
- formazione del personale addetto;
- pesatura, registrazione e tracciabilità dei carichi;
- stoccaggio dei rifiuti conformi e non conformi in aree dedicate;
- gestione delle non conformità secondo un sistema documentato.
Per le imprese con certificazione ambientale (EMAS o ISO 14001), tali procedure sono integrate nel sistema di gestione ambientale.
c) Processo di lavorazione minimo e deposito
- il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri;
- il recupero avviene tramite operazioni meccaniche (come ad esempio frantumazione, vagliatura, separazione di metalli e materiali indesiderati);
- durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
d) Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato
- ogni lotto deve rispettare i parametri della tabella 2, in cui i limiti di concentrazione degli inquinanti sono differenziati in base alla destinazione d’uso
- ogni lotto deve essere sottoposto al test di cessione per verificare il rispetto dei limiti di concentrazione stabiliti nella tabella 3. Il test viene eseguito secondo la UNI 10802 (appendice A) e la UNI EN 12457-2.
e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell’aggregato recuperato
Il DM stabilisce che l'aggregato recuperato, per l’utilizzo, dovrà rispettare specifiche norme tecniche di settore, elencate in Tabella 4, per l'attribuzione della marcatura Ce di cui al Regolamento (UE) n. 305/2011. Questo ad esclusione degli usi derogati dal medesimo regolamento.
L’aggregato recuperato può essere utilizzato solo per gli scopi previsti nell’allegato 2, nel rispetto delle norme tecniche identificate nella tabella 5 e, per la produzione di clinker, dei parametri prestazionali riportati in Tab. 6.