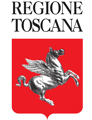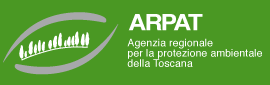Letture verdi, a colloquio con Giulio Betti
Per la rubrica Dialoghi con l'autore e l'autrice, abbiamo rivolto alcune domande a Giulio Betti, autore del libro "Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico"
Giulio Betti è meteorologo e climatologo, attivo presso l'istituto di Bioeconomia del CNR (IBE) e il Consorzio LaMMA. Conosciuto anche come divulgatore scientifico, attivo sui social, scrive articoli e partecipa a eventi pubblici per fare conoscere ad un pubblico vasto e eterogeneo cosa sia davvero il cambiamento climatico. Infatti, il libro "Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico" punta a smontare le "fake news" ed evidenziare le "trappole" che, troppo spesso, rendono difficile capire veramente quali siano gli effetti del clima che muta e cosa possiamo fare per contrastare quest'importante crisi che connota la nostra contemporaneità.
Queste le risposte di Giulio Betti.
Partiamo dal titolo, “Ha sempre fatto caldo” e di conseguenza non c’è molto di cui preoccuparsi. È davvero così o si tratta di una credenza erronea sul cambiamento climatico?
Il titolo è ovviamente provocatorio e ironico e parte proprio dall'equivoco intorno al quale si incardina buona parte della disinformazione sul cambiamento climatico: la differenza tra meteorologia e clima.
Chi nega spesso porta come esempio ondate di calore o eventi estremi del passato, senza però descriverne la differenza rispetto ad oggi in termini di frequenza, intensità e durata. Proprio qui si nasconde l'inganno, un discorso è dire che le ondate di calore ci sono sempre state, un altro è mostrare che sono triplicate rispetto al passato.
Come possono coesistere gelo scandivano, nevicate eccezionali (ad es. Marmolada maggio 2025, deserto Atacama noto come luogo più arido della Terra, giugno 2025), e riscaldamento globale?
Coesistono proprio in virtù della differenza che intercorre tra evento meteorologico e tendenza climatica. Una nevicata eccezionale o un'ondata di freddo restano eccezioni se vengono nettamente superate, in termini di frequenza e intensità, da periodi di caldo anomalo o di scarsità di nevicate. Il trend lo fanno gli eventi meteorologici più ricorrenti in un dato intervallo temporale, se prevalgono periodi di caldo anomalo la tendenza sarà al rialzo, da qui non si scappa.
Quali sono i fattori principali che a suo parere alimentano il negazionismo o lo scetticismo rispetto al cambiamento climatico e quali sono gli strumenti più efficaci per prevenirli?
Paura e opportunismo.
La prima caratterizza coloro che sono terrorizzati dal cambiamento e che non vogliono accettare l'esistenza di una crisi così enorme.
La seconda è tipica di chi, pur conoscendo il problema, lo sfrutta cinicamente a proprio vantaggio incurante delle conseguenze.
Per combattere il negazionismo la risposta è la corretta informazione, perché spesso il primo parte da narrazioni fasulle e mezze verità di facile fruizione. Inoltre dobbiamo coinvolgere i decisori mostrando loro che la transizione energetica non è il bagno di sangue che la disinformazione descrive, ma una grandissima opportunità sociale, ambientale ed economica.
Può illustrare a un pubblico di non esperti/e come siamo messi dal punto di vista dello scenario climatico globale? Quali sono le differenze tra adattamento e mitigazione? Può farci alcuni esempi?
L'attuale fase storica è particolarmente buia, perché il mondo è attraversato da un'onda oscurantista e ostile alla scienza. Questo sta rallentando molto il processo di mitigazione e adattamento con conseguenze assai gravi. Tuttavia esistono esempi viventi ed esportabili di lotta al cambiamento climatico antropico. Il web ne è pieno, basta cercarli!
L'adattamento riguarda le risposte agli impatti del cambiamento climatico, in altre parole le opere e le azioni da mettere in campo per attenuare gli effetti degli eventi estremi da esso provocati. La mitigazione invece si riferisce all'abbattimento delle emissioni di CO2, sia attraverso un loro drastico taglio, sia attraverso il loro assorbimento attraverso processi di rinaturalizzazione (che sono utili anche per l'adattamento).
Può aiutarci a capire meglio che cosa siano le “ondate di calore”, come hanno origine, quali effetti (es. barriere coralline) e come tutelarsi. Per quali motivi le ondate di calore sono aumentate significativamente in Italia e in Europa?
Le ondate di calore sono fasi caratterizzate da temperature ben superiori alle medie (oltre il 90° percentile) che insistono per più giorni (almeno 6 consecutivi). Oltre a quelle atmosferiche esistono anche le ondate di calore marine, responsabili dei drammatici sbiancamenti dei coralli visti in questi anni. Animali e piante non possono difendersi dalle ondate di calore, purtroppo, noi sì. Città più verdi e rifugi climatici sono la risposta più efficace per diminuire l'impatto del caldo anomalo estivo nei grandi agglomerati urbani, in particolare sui segmenti di popolazione più fragile.
L'Europa paga la sua posizione geografica, a cavallo tra il deserto del Sahara e l'Atlantico. Un nodo particolarmente sensibile al cambiamento climatico che rende il nostro continente più esposto di altri. Basti pensare che l'Europa si scalda quasi il doppio rispetto agli USA.
Cambiamento climatico e adattamento in agricoltura: alcuni esempi. Quali sono le pratiche da adottare per arginare le minacce dei fenomeni metereologici estremi ?
L'agricoltura deve essere lungimirante e programmare il futuro in base agli scenari climatici più probabili. Lungimiranza che si struttura intorno alla protezione attiva contro gli fenomeni estremi (grandine e caldo anomalo in primis), la messa a dimora di nuove colture più resistenti al caldo e alla siccità, lo stoccaggio e il risparmio idrico, l'ottimizzazione massima dell'irrigazione e il trasferimento di particolari produzioni a quote più elevate.
Quale approccio e quali strumenti possiamo suggerire/offrire a coloro che intendono orientarsi e documentarsi nel più ampio dibattito pubblico sul cambiamento climatico?
La corretta informazione. Il web è un contenitore di informazioni, talvolta sono ottime, altre volte sono false o inattendibili. Il mio consiglio è quello di diffidare sempre da spiegazioni troppo semplici rispetto ad eventi complessi; non farsi ingannare da meme o slogan un tanto al chilo. La scienza del clima è complessa e va compresa attraverso i testi e le voci degli esperti. Trovare spazi dove i fenomeni vengono spiegati e non urlati, dove della crisi del clima non si parli solo in termini catastrofici, ma anche in termici di soluzioni.
Nella sua veste di divulgatore scientifico che lavora spesso nelle scuole, quali pratiche e metodologie ritiene più efficaci per avvicinare giovani studenti che mostrano disinteresse o scetticismo verso questi temi?
Comunicare la speranza e le opportunità. La maggior parte dei giovani non è disinteressata o scettica, bensì disillusa. Una disillusione della qualche siamo responsabili anche e soprattutto noi, le generazioni più vecchie. La chiave è parlare con loro, fare divulgazione attraverso esempi pratici e soprattutto non descrivere soltanto la crisi, ma proporre soluzioni e opportunità (esistono, sono molte, ma non se ne parla abbastanza). Dobbiamo essere propositivi e non giudicanti. Dobbiamo sostenere i movimenti giovanili e le idee che arrivano da chi erediterà questo mondo.
Infine, qual è il significato dell’immagine di copertina: un T-Rex su una tavola da surf?
È una copertina che vuole portare un po' di leggerezza in un argomento serio come quello del cambiamento climatico. L'intento è quello di mostrare che si può parlare di crisi, senza necessariamente partire sconfitti, che si può smontare la disinformazione con l'ironia e con un irriverente sorriso sulle labbra.